
Pagina Iniziale
GLI ANTIPASTI DELLA CUCINA MARCHIGIANA
il classico pranzo sulla costa marchigiana viene fatto iniziare,solitamente,con il famoso brodetto,
di cui esistono diverse versioni.Le più diffuse sono quella anconetana -a base di 13 qualità di pesce
diverso-e quella di porto Recanati,
.jpg) in cui il pesce viene cotto in uno speciale sugo a base di zafferano.
al brodetto si possono abbinare le gustose frittelle di pesce persico,passate nella pastella a base di farina
ed uova e poi fritte in olio di oliva.spostandosi verso l'interno, invece, abbondano i gustosi e tipici antipasti a base di tartufi
bianchi o neri, magari accompagnati da profumatissimi e prelibati funghi
in cui il pesce viene cotto in uno speciale sugo a base di zafferano.
al brodetto si possono abbinare le gustose frittelle di pesce persico,passate nella pastella a base di farina
ed uova e poi fritte in olio di oliva.spostandosi verso l'interno, invece, abbondano i gustosi e tipici antipasti a base di tartufi
bianchi o neri, magari accompagnati da profumatissimi e prelibati funghi
I Piatti Tipici Marchigiani.
Da provare assolutamente sono quelle pietanze in cui i sapori e gli aromi tipici della montagna sono abilmente mescolati
a quelli marinari come, ad esempio, gli spaghetti mari e monti, a base di calamari e funghi, e la rana pescatrice e porchetta, a base di rana e fagioli.
Altri primi piatti tipici della cucina marchigiana sono le lasagne all´ascolana, condite con il tartufo bianco, i cappelletti in brodo
di cappone, le tagliatelle con i calamari e le molecche (code di scampi dal guscio tenero), la minestra di ceci e maiale e le classiche
tagliatelle al tartufo, rigorosamente bianco. Anche per i secondi piatti le pietanze sono diverse a seconda che ci si trovi sulla costa o,
al contrario, in qualche caratteristica località di montagna. Tipiche pietanze costiere sono il merluzzo alla marchigiana, condito con un sugo di pomodoro,
le sarde di Ancona, impanate e cotte al forno, il baccalà in bianco,.jpg) con salsa verde a base di prezzemolo e lo stoccafisso, preparato in umido con patate o in `potacchio´,
ossia brasato con pomodoro, acciughe, aglio, rosmarino, prezzemolo e peperoncino. Tra i piatti tipici di montagna sono da provare la polenta costarella e salsicce,
la minestra di ceci e maiale, le uova fritte nel burro e cosparse di filetti di tartufo e l’insalata di funghi e tartufi.
con salsa verde a base di prezzemolo e lo stoccafisso, preparato in umido con patate o in `potacchio´,
ossia brasato con pomodoro, acciughe, aglio, rosmarino, prezzemolo e peperoncino. Tra i piatti tipici di montagna sono da provare la polenta costarella e salsicce,
la minestra di ceci e maiale, le uova fritte nel burro e cosparse di filetti di tartufo e l’insalata di funghi e tartufi.
dialetto
Bisogna inoltre sottolineare che alcune forme di origine veneta si trovano nelle città di mare e nei porti, come Senigallia ed Ancona.
I termini gallo-italici si distinguono per la presenza dei suoni "ü" e "ö"; dalla caduta di alcune vocali, come in "stimana" per settimana;
per l'inversione (metatesi) della consonante tonica, come in "arpià" per "ripigliare", "arcudà" per "ricordare"; per la caduta di alcune vocali,
come in "pover" per "povero", "pranz" per "pranzo"; per il cambiamento (lenizione) della vocale sorda,.jpg)
come in "segondu" per "secondo", "diga" per "dica", "figu" per "fico"; l'alterazione di tutte le vocali doppie.
Nel secondo tipo di dialetto, data la sua ristrettezza, è difficile stabilire delle regole precise, ma abbiamo alcuni caratteri
specifici, come il cambio di "i" in "e" e viceversa, come in "pelo" al plurale "pijie", "pegno" al pl. "pigne"; "vetro" al pl. "vitre"; nei verbi, come in "meto" (mietere), che in seconda persona diviene "tu miete"; il cambio "uo" in "o", così "buono" e "bona", "posso" e "puoe". Un'altra particolarità è l'assimilazione delle lettere, così caldo diviene "callo", grande "granne", quando "quanno", etc.
Nelle iniziali in "g" si hanno inoltre delle variazioni, così "gioventù" diventa "gioentù", ad Ancona, ma a Macerata "giovanotti" diviene "gghioenotti", con un rafforzamento del suono duro "g".
Nel territorio intorno a Camerino, invece, il dialetto marchigiano si mantiene più puro, con al sua caratteristica finale in "u". Si ha inoltre un passaggio della "e" chiusa in "a", come in "male" per "mela", e della "o" in "e", come in "fiere" per "fiore". A Montalto, invece la "e" chiusa passa in "ai", si ha quindi "maila" per "mela".
Per quel che riguarda il vocabolario, la situazione del marchigiano è piuttosto composita. Citiamo alcuni esempi: nella prima zona si ha "bagé" per maiale; "butrigò" per precipizio; ad Ancona si ha "impalichì" per appisolarsi; "strofu" per cencio; a Macerata, "curtina" è podere; "sarvai" è imbuto; ad Ascoli Piceno, "furia"
vuol dire "molto"; "fracchia" fango; "rua", dal francese "rue", significa "via".
Arte
eccellenze artistiche fanno delle Marche una delle regioni d’Italia più ricche di beni culturali: 500 piazze, più di 1000 monumenti significativi, 37 rocche, 106 castelli, 15 fortezze e 170 torri
migliaia di chiese di cui 200 romaniche, 96 abbazie, 183 santuari, 72 teatri storici tutti restaurati e in attività. Cominciando dall’entroterra di Pesaro-Urbino, si incontrano centri che ancora oggi rievocano i fasti rinascimentali; parliamo di Pennabilli, da cui erano originari i Malatesta oppure San Leo, città d’origine dei Montefeltro.
la stessa a Pesaro fu sede dei Della Rovere fino al 1631, Signoria fu devoluta allo Stato Pontificio. Ad Urbino, invece, è lo stesso palazzo Ducale, voluto da Federico da Montefeltro, ad incarnare la perfetta dimensione signorile e di corte raggiunta dalla città. Dal 1912 è qui ospitata la Galleria Nazionale delle Marche, che custodisce capolavori di Raffaello, Piero della Francesca, Tiziano, Paolo Uccello ecc. Ma Francesco di Giorgio Martini costellò l’intero Ducato di rocche fiabesche quali San Leo, dove fu tenuto prigioniero e morì il Conte Cagliostro, Mondavio, oppure Cagli e infine Sassocorvaro la cui rocca ubaldinesca racchiude il nuovo
museo dedicato alle opere d’arte in pericolo e denominato “Arca dell’Arte”. fortezze martiniane di Paolo e Francesca di dantesca memoria e dove ancor’oggi si respira un’incredibile atmosfera medievale, i vicoli del borgo o lungo la cinta muraria irta di merli.
Anche Fano è testimone della potenza della famiglia Malatesta che qui abitò fino al 1463. incontriamo prima Senigallia, in provincia di Ancona, anch’essa un tempo parte del ducato urbinate, come testimonia la rocca roveresca e subito dopo Ancona, dove è possibile ammirare uno dei più bei monumenti romanici dell’Italia centrale, la Cattedrale di San Ciriaco, altri
edifici di pregio tra cui la Loggia dei Mercanti, la Chiesa di San Francesco o la Pinacoteca Civica. Pochi chilometri a sud di Ancona troviamo Loreto con il più grande santuario mariano d’Italia, visitato ogni anno da milioni di pellegrini provenienti da tutto il mondo la cui tradizione è legata alla Santa Casa di Nazareth che, leggenda vuole, venne trasportata dagli angeli in volo per salvarla dall’invasione della Palestina da parte dei Maomettani nel 1294. c’è il “borgo” di Recanati, che vive nel culto di Giacomo Leopardi e bla Torre Antica del passero solitario, la piazzetta del Sabato del Villaggio, l’umile casa di Silvia per poi giungere sino al Colle dell’Infinito dove è scolpito il primo verso del celebre canto “Sempre caro mi fu quest’ermo colle”. Meritano inoltre una visita le città di Osimo, ricca di vestigi antiche,
Offagna, dominata dalla scenografica Rocca, Corinaldo, che vanta una cinta muraria tra le più spettacolari della regione ed un centro storico e Sassoferrato, di antica origine romana di cui sono rimasti resti di strade selciate, edifici e mura. la valle dell’Esino è dominata da Jesi, città natale del musicista G. Battista Pergolesi e sede di una pregevole Pinacoteca dove è custodito uno dei maggiori capolavori di Lorenzo Lotto, la Pala di S. Lucia. Anche questa città è circondata da mura ancora sostanzialmente integre ed il suo centro storico, molto ben conservato, è caratterizzato da quartieri medievali, palazzi gentilizi e splendide chiese.
a Fabriano, città medievale che diede i natali al più illustre e raffinato esponente del Gotico Internazionale, Gentile da Fabriano, e nota in tutto il mondo, sin dal 1200, per la lavorazione della carta. Da qui è facile raggiungere Camerino, in territorio maceratese. La cittadina fu caratterizzata, sotto la Signoria dei Da Varano, da una intensa fioritura economica ed artistica ed attualmente è sede di uno degli atenei più antichi ed illustri d’Europa. Oltre Camerino si incontra prima Tolentino, dove sorge uno dei santuari più noti dell’Italia centrale, la Basilica di San Nicola, e poi San Severino Marche che, tra il ‘300 ed il ‘400 divenne uno dei maggiori centri del Gotico Internazionale. Matelica, con la sua cinquecentesca Fontana Ottagonale, le chiese e gli edifici monumentali di romanica memoria e la raccolta di arazzi del ‘500 e ‘700 conservata nel Museo Piersanti. a Macerata la città venne fondata in collina per sfuggire alle incursioni barbariche ed è ricca di arte rinascimentale, barocca e sett
ecentesca.
Tra i monumenti più significativi ricordiamo l’Arena Sferisterio, sede tra le più importanti Stagioni Liriche estive, Piazza della Libertà e la Loggia dei Mercanti, la Torre
dell’Orologio e numerosi musei, nonché l’antica Università che fanno della città un punto di riferimento culturale. Infine Sarnano, piccolo comune di montagna, famoso per il cotto rosso dei tetti delle case, le strade strette e ripide, le terme e gli impianti sciistici. nel territorio della Provincia di Ascoli Piceno, si incontra Fermo, uno dei più fiorenti centri marchigiani in epoca romana e medievale – lo testimoniano i numerosi musei naturalistici e archeologici –ben conserva le monumentali cisterne romane, una splendida piazza fiancheggiata da portici eretti nel 1569, il cinquecentesco Palazzo dei Priori all’interno del quale è ospitata
la Pinacoteca Civica che vanta numerosi dipinti di scuola veneta e marchigiana nonché una preziosissima tela di Rubens.Più a sud incontriamo Ripatransone, con il suo suggestivo centro storico ed il vicolo più stretto d’Italia, e, a pochi chilometri da qui, Offida, degna di nota non solo per le sue antichissime origini, le mura, il Teatro del Serpente Aureo, gioiello di concezione barocca o l’Abbazia di S. Maria della Rocca, ma anche per la tradizione, risalente al XV secolo e tutta tipicamente femminile, del merletto a tombolo. oggi, durante la stagione estiva, è facile imbattersi, , in donne sedute a lavorare a sorprendente velocità producendo veri e propri capolavori famosi in tutto il mondo. La città di Ascoli Piceno, capoluogo di provincia, è definita la città dal cuore caldo per il colore caldo del travertino brunito sono state edificate le sue case, le sue piazze e i suoi monumenti: il Teatro ed il ponte Augusteo, la chiesa di San Francesco, il Duomo e il Battistero e la Piazza del Popolo sede, in a gosto, della famosa Quintana, una delle più straordinarie storiche d’Italia, uno spettacolo offerto da sei cavalieri in lizza per la competizione trai i sei sestieri cittadini che dalla sfilata del corteo. Una visita anche i centri di Acquaviva Picena, dominata da una imponente fortezza, Montefortino, che conserva tutta l’atmosfera medievale delle strette vie e delle hcase in pietra e cotto, e Falerone, dove è possibile visitare i resti dell’antica città romana di Faleria con il suo teatro recentemente restaurato. Da non perdere Sant’Elpidio a Mare, quasi i racchiusa tra le mura medievali e conserva l’antica Torre Gerosolimitana eretta dai Cavalieri di Malta, ed il Palazzo Comunale che custodisce un polittico del Crivelli e un trittico del Garofalo. Infine Arquata del Tronto, comune d’Italia compreso in due parchi nazionali: quello dei Monti Sibillini e quello del Gran Sasso e dei Monti della Laga.
economia
Turismo nelle Marche
Sviluppato in maggior parte nelle zone costiere, il turismo è ben presente nelle Marche che offrono un buon assortimento di strutture hotel e alberghi destinati alla ricettività estiva sia per i turisti Italiani che stranieri che frequentano in buon numero le sue spiagge. Le zone balneari più conosciute ed attrezzate sono quella del Conero, Porto San Giorgio, Gabicce, Grottammare e Senigallia, tutte dotate di infrastrutture ed attrezzature moderne ed effficienti.
Industria nelle Marche
Le Marche negli ultimi anni hanno avuto un buon sviluppo del settore industriale,gli impianti si trovano prevalentemente attorno alla costa e riguardano i settori navali e le raffinerie, nonché alcuni impianti chimici ad Ancona e Civitanova. Le aziende più piccole sono invece sparse in tutta la regione, da citare per importanza a livello nazionale il settore calzaturiero e altrettanto importante l'attività della pesca, effettuata anche con grandi imbarcazioni e moderne attrezzature.
Agricoltura delle Marche
In regione è ben presente anche l'agricoltura, con coltivazioni di frutta, olive, frumento, ortaggi e uva da vino, nelle zone interne resiste ancora una agricoltura più povera ed ancorata alle tradizioni rurali ma poco redditizia. Per questo motivo molti degli abitanti delle zone interne si sono trasferiti negli anni verso le zone costiere dove è più facile fare lavori a maggior reddito, nelle industrie e nel turismo.
parchi naturali delle marche
Le aree protette delle Marche occupano 86.630,54 ha di terra, pari circa all'8% del'intero territorio regionale. Il sistema regionale tutelato è costituito da 2 Parchi Nazionali: Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga; 4 Parchi Regionali: Parco del Monte Conero, Parco del Sasso Simone e Simoncello, Parco del Monte San Bartolo, Parco della Gola della Rossa e di Frasassi; due Riserve Naturali: Riserva Naturale Montagna di Torricchio e Riserva Naturale Abbadia di Fiastra. Tra le aree protette ci sono anche 2 Oasi del WWF: Oasi WWF Ripa Bianca di Jesi, Oasi WWF Bosco di Frasassi. A queste aree protette istituite dallo Stato con la Legge n. 394/1991 e dalla Regione Marche con la Legge n. 15/1994, si aggiungono altre aree finalizzate alla conservazione della Natura come gli 80 siti Bioitaly, le Aree floristiche protette (L.R. 52/1974), le ZPS ( Zona di Protezione Speciale individuate in base alla Direttiva europea per la tutela degli Uccelli), le Oasi di Protezione della Fauna istituite dalle Province nell'ambito della pianificazione faunisitco venatoria (L.R. n. 7/1995). La realizzazione del sistema regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali nelle Marche ha come obiettivi prioritari: la salvaguardia delle specie di eccezionale valore scientifico, naturalistico e culturale; il mantenimento di ambienti essenziali per il mantenimento dei sistemi ecologici fondamentali; la sperimentantazione di un processo di crescita in cui la conservazione dell'ambiente possa interagire in modo sinergico con l'esigenza di migliorare lo status socio-economico delle popolazioni locali.
territorio
Le Marche sono l’unica regione con il nome al plurale derivante dal suo assetto feudale. Si estende tra la dorsale appenninica ed il mare Adriatico presentando aspetti geomorfologici e paesaggistici di grande varietà. Si va dall’ambiente dell’alta montagna appenninica alle lunghe spiagge del litorale adriatico attraverso una distesa collinare. L’Appenino umbro-marchigiano costituisce il confine naturale con l’Umbria che coincide in gran parte con quello amministrativo. Le pianure sono una ristretta fascia a ridosso della costa e le aree prospicienti il medio e basso corso dei fiumi che solcano la regione.
La montagna Il territorio montano interessa il 36% dell’intera superficie regionale. Con andamento quasi parallelo alla dorsale principale si sviluppano rilievi che delimitano subregioni appenniniche. Un esempio è la conca di Camerino che va dai Sibillini fino al Catria. La dorsale principale inizia, a sud, con le cime del gruppo della Laga e poi con la catena dei Sibillini. A nord con i monti Fema, Cavallo, Pennino, Cucco, Catria, Nerone, Carpegna e si riallaccia all’Appenino tosco-emiliano. Un altro segmento verso oriente comprende i monti Fiegni, Letegge, San Vicino e più a nord i monti Pietralata e Paganuccio che formano la selvaggia gola del furlo
Le acque
Il territorio montano interessa il 36% dell’intera superficie regionale. Con andamento quasi parallelo alla dorsale principale si sviluppano rilievi che delimitano subregioni appenniniche. Un esempio è la conca di Camerino che va dai Sibillini fino al Catria. La dorsale principale inizia, a sud, con le cime del gruppo della Laga e poi con la catena dei Sibillini. A nord con i monti Fema, Cavallo, Pennino, Cucco, Catria, Nerone, Carpegna e si riallaccia all’Appenino tosco-emiliano. Un altro segmento verso oriente comprende i monti Fiegni, Letegge, San Vicino e più a nord i monti Pietralata e Paganuccio che formano la selvaggia gola del furlo
Le acque
La rete idrografica ha una struttura molto particolare, costituita da corsi d’acqua paralleli fra loro che discendono gli Appennini .Questa complessa configurazione orografica caratterizza vallate separate l’una dall’altra da cortine di rilievi che hanno determinato un isolamento tra le valli che si riscontra tuttora a causa della mancanza di un efficiente rete viaria pedemontana. Da un bacino all’altro si avverte l’effetto della plurimillenaria mancanza di contatti umani che si riflette nelle diversità di usi, costumi, tradizioni e nelle inflessioni dialettali e cadenze idiomatiche. I fiumi delle Marche sono da nord a sud: Marecchia, Conca, Foglia, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone, Potenza, Chienti, Tenna, Aso e Tronto, che sfociano tutti in Adriatico. Il Nera, affluente del Tevere, scorre per un breve tratto in territorio marchigiano per poi passare i confini regionali con l’Umbria. Gran parte di questi fiumi forma anguste gole di straordinaria bellezza quali la gola del Furlo, la gola di Frasassi, la gola della Rossa, le gole della Valnerina, la gola del Fiastrone, la gola di Pioraco e la gola dell’Infernaccio. Per quanto riguarda i bacini lacustri, l’unico lago naturale è quello di Pilato, a 1940 m di quota, tra le rocce del massiccio Vettore nel gruppo dei Sibillini.
Il dolce paesaggio collinare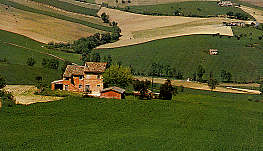 Il paesaggio collinare interessa il 53% del territorio ed è un tratto inconfondibile di questa terra. Si tratta di alture marnoso-arenacee che la natura ha distribuito sia a nord che a sud. L’uomo poi vi ha disegnato precisi appezzamenti delle più svariate forme geometriche con interminabili filari di pioppi e punteggiati da alberi d’ulivo o da rigogliose vigne. Alla sommità dei colli sorgono le ‘città balcone’ arroccate da secoli e testimoni della storia. Recanati, Urbino, Fermo, Camerino, Cingoli, Osimo, San Ginesio, Macerata, Loreto sono alcune delle più belle ‘città belvedere’. Nel Montefeltro, ai confini con la Toscana e la Romagna, prevale un ambiente aspro con scoscesi speroni rocciosi e giganteschi contrafforti di pietra come quelli su cui sono aggrappati San Leo e la Repubblica di San Marino. Più a mezzogiorno il paesaggio si addolcisce e compaiono dei colli in una successione sempre più sfumata. Nella punta meridionale dell’Ascolano, a ridosso del confine con l’Abruzzo, il terreno si increspa con maggior decisione, i pendii più ripidi e gli stacchi tra collina e pianura diventano più netti.
Il paesaggio collinare interessa il 53% del territorio ed è un tratto inconfondibile di questa terra. Si tratta di alture marnoso-arenacee che la natura ha distribuito sia a nord che a sud. L’uomo poi vi ha disegnato precisi appezzamenti delle più svariate forme geometriche con interminabili filari di pioppi e punteggiati da alberi d’ulivo o da rigogliose vigne. Alla sommità dei colli sorgono le ‘città balcone’ arroccate da secoli e testimoni della storia. Recanati, Urbino, Fermo, Camerino, Cingoli, Osimo, San Ginesio, Macerata, Loreto sono alcune delle più belle ‘città belvedere’. Nel Montefeltro, ai confini con la Toscana e la Romagna, prevale un ambiente aspro con scoscesi speroni rocciosi e giganteschi contrafforti di pietra come quelli su cui sono aggrappati San Leo e la Repubblica di San Marino. Più a mezzogiorno il paesaggio si addolcisce e compaiono dei colli in una successione sempre più sfumata. Nella punta meridionale dell’Ascolano, a ridosso del confine con l’Abruzzo, il terreno si increspa con maggior decisione, i pendii più ripidi e gli stacchi tra collina e pianura diventano più netti.
Elemento multimediale non supportato!
le tradizioni delle marche
Ascoli Piceno ha origini antichissime, il suo passato plurimillenario (esisteva prima di Roma ) é tutto scritto nei resti , nelle testimonianze rimaste a sfidare i secoli, tuttora visibili e visitabili . Esistono le costruzioni come le grotte dell’Annunziata ,i resti di un tempio pagano , inseriti nella Chiesa di S. Gregorio, la Porta Gemina (I sec. a.c. ) il ponte Augusteo(tuttora transitabile ed efficiente) , il teatro Romano giunti fino ai giorni nostri. Perché la caratteristica di Ascoli Piceno è quella di essere un autentico museo all’aperto, che comprende gli stili delle varie epoche,dove la presenza é suggestiva ed incredibile e copre tutto l’arco di tempo che va dal Medio Evo al Rinascimento. Il tessuto urbanistico é passato dall’organizzazione romana a quella medioevale e questo passaggio é presente nelle sue piazze, come quella del Popolo -ritenute una delle più armoniche e spettacolari d’Europa- o dell’Arengo, nelle sue vie strette e contorte chiamate Rue, nelle sue porte , come vedremo, danno anche i nomi ai Sestieri della Quintana , nelle sue monumentalità come i templi (S. Francesco,Cattedrale, Battistero, SS. Vincenzo e Anastasio, S. Vittore, S. Maria Intervineas) o Palazzi (dei Capitani, dell’Arengo, Malaspina) sempre solo per fare qualche esempio, o nelle sue Torri (non per nulla Ascoli è chiamata la città delle Cento Torri). Ebbene ,visitando il capoluogo Piceno, ognuno potrà rendersi subito conto di quale storia, quali costumi, quali atmosfere intende rievocare la Quintana. E’ per questi motivi che la Quintana é stata considerata dal 1982 leader delle Rievocazioni Storiche, mentre Siena lo é per le Rievocazioni in costume. E’ anche leader nelle manifestazioni della Regione Marche , figura nelle Lotterie Nazionali, è Stata chiamata in tutto il mondo(USA, Canada, Europa) a dare spettacolo con i suoi personaggi, con le sue figure, con i suoi armati, con le sue dame, con i suoi sbandieratori e musici, insomma a dare un’immagine palpabile di quella che fu l’antica Cavalleria del Quattrocento!
E allora veniamo alla Quintana di Ascoli
L’etimo è ancora incerto, c’é chi la vuole far derivare dal francese Quintane o dal provenzale quintana, chi dal latino quintus (negli accampamenti romani era la strada tra il V e il VI manipolo dove i legionari probabilmente facevano i loro esercizi militari ). Chi, infine, propone Quintana come era chiamato il simulacro , fantoccio di un guerriero ( moro, saraceno, infedele, nomi legati alla letteratura ed alle cronache delle crociate).
Val la pena, a questo punto, segnalare al lettore , che ad Ascoli esiste un Centro Studi sui Giochi Storici che organizza convegni, mostre, pubblicazioni e dibattiti, proprio alla ricerca di tutte le possibili origini della Quintana, con l’apporto dell’archivio di stato, della Biblioteca comunale e di esperti e studiosi medioevalisti. La giostra della Quintana é una gara di abilità e destrezza nella quale si cimentano per la conquista del Palio, sei cavalieri, ciascuno rappresentante,un Sestiere cittadino, come nell’antica suddivisione urbanistica. Ricordate questi nomi dei Sestieri, che sono alla base dell’acceso agonismo che infervora gli ascolani: Piazzarola, Porta Maggiore, Porta Romana, Porta Solestà, Porta Tufilla, Sant’Emidio.
Le Giostre furono un prodotto del feudalesimo e della cavalleria, e si riallacciano, per ciò che riguarda il fine di esercitarsi nell’arte militare, ai giochi guerreschi propri di quasi tutti i popoli. Essi furono molto numerosi durante i secoli XII e XIII, in tutte le città grandi e piccole.Naturalmente anche più dei tornei furono numerose le Giostre dal sec. XIII in avanti, e tanto vivo e diffuso fu l'amore per tali feste, che se ne vollero correre dappertutto. Nella seconda metà del cinquecento le Giostre risentono delle nuove idee sociali e politiche . Talché accanto ai solenni spettacoli offerti dai principi e dai signori, non mancavano le giostre popolari, cui prendono parte non solo i borghesi, ma anche gli artigiani e i loro famigliari. All’inizio del Quattrocento si era risvegliato quasi dappertutto in Italia lo spirito militare e guerresco, e le Giostre avevano raggiunto in quell’epoca un magnificenza a cui prima non si erano nemmeno avvicinate. E’ appunto sul finire del sec. XIV, verso il 1378, in coincidenza con la redazione degli Statuti del popolo, conservati ancora oggi nell’Archivio storico della città, che abbiamo notizia della Giostra della Quintana di Ascoli che, secondo alcuni , era per l’appunto una giostra e non un torneo. Questo tipo di distinzione, che é del Muratori (Dissertazione XXIX nelle antichità italiane), non è puramente nominale:le Giostre anche quando consistevano in finti combattimenti, erano più cruente.Abbiamo ,comunque, la sicurezza che questo tipo di tradizione non si è mai interrotta negli anni e ha subito una continua evoluzione fino a raggiungere i connotati odierni
IL CORTEO STORICO
E siamo alla parte più attraente , più spettacolare della Quintana.Siamo al Corteo Storico che vede materializzarsi un lungo serpente, ordinato e colorato dai velluti, dai damaschi, dalle trine di Dame e Damigelle, dai severi costumi delle Magistrature, dai rami e dagli argenti, dai bronzi di corazze,elmi ed armi ,dai paludamenti variopinti delle Corporazioni, dagli scoppi di colori e disegni dei cento e cento drappi che gli sbandieratori lanciano al cielo, per un totale di almeno 1400 /1500 partecipanti.
Un corteo che, nel lento passo segnato dal rullare dei tamburi e dagli squilli argentini delle lunghe trombe (chiarine) , sembra uscire da un affresco del Quattrocento e realizzarsi, oniricamente, nel suo ambiente storico naturale : le tortuose rue, le magnifiche piazze, le ombre degli antichi manieri,torri e palazzi. Ecco dunque una visione (tra virgolette) da non perdere!
Lo stesso sindaco della città, in carica, anche Lui in un severo ed elegante costume d’epoca, apre il corteo quale Magnifico Messere; è seguito dalle Magistrature che sono rappresentate dagli assessori comunali in carica e altri maggiorenti come i consiglieri provinciali, regionali, della Camera di Commercio, da presidenti di Enti e dai vari rappresentanti delle corporazioni e ordini (medici, avvocati, ingegneri, artigiani).
Una singolarità, questa, che non aveva eguale nelle altre rievocazioni.
A questo punto è difficile dettagliare tutte le figure che sfilano : ricordiamo le Guardie nere comunali che fanno da scorta al Magnifico Messere e al Gonfaloniere civico con i suoi valletti.
Quindi il folto stuolo dei Musici e degli Armigeri che scortano il Palio. Si tratta di un drappo di seta che ogni anno viene dipinto da un artista di chiara fama, con un soggetto sempre legato alla Quintana.Esso rappresenta l’ambito premio che andrà al Sestiere vincente e che, una volta conquistato, sarà poi gelosamente conservato nelle sedi di Sestiere e riportato in corteo (con gli altri trofei vinti) negli anni seguenti.
Non dimentichiamo che al corteo partecipano anche le rappresentanze dei Castelli a suo tempo devoti e legati ad Ascoli Piceno (Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Castorano, Folignano, Patrignone, Porchia, Ripa Berarda, Montemonaco, Roccafluvione).
Tutte le località nel circondario Piceno, anch’esse ricche di testimonianza storico artistiche e che nell’ambito dei loro gruppi, usano proporre le loro caratteristiche monumentali o di costume (Dame e Castellani di manieri , Corporazioni dei mestieri soprattutto artigianali, cacciatori, pastori con cani e con mazze di radica ed altro ancora ). E riprendiamo la riassuntiva illustrazione del corteo, che vede nei Sestieri l’essenza sempre viva della città.
Ogni Sestiere apre il proprio gruppo con un Console seguito dalle nobiltà del rione, dai nobili e dalle varie Corporazioni di professioni e mestieri che rispondono a tali qualifiche anche nella vita quotidiana. Ogni Sestiere figura con prestanti cavalieri, con armigeri alfieri e vessilliferi nonché con un suo gruppo di tamburini. Quindi, circondata da paggetti la Dama ,la signora del Sestiere, scelta tra le più belle del rione, seguita dalle Damigelle anch’esse accuratamente scelte tra le più significative bellezze muliebri.Ogni anno questa cernita non è delle più facili poiché tutte le giovani del Sestiere sanno quale ambito onore rappresenti il partecipare al corteo storico: un riconoscimento, cioè, che ha molto più accanito valore di una moderna elezione di miss.
Sfila ,quindi il personaggio più acclamato, temuto, ammirato del Sestiere: il Cavalier Giostrante, colui cioè che si batterà contro il Saraceno o Moro per la conquista del Palio . Cavalier giostrante e cavallo, rappresentano un binomio che tiene preoccupati per tutto l’anno i "sestieranti" e priva del sonno, negli ultimi giorni che precedono la Giostra, tutti coloro che hanno a cuore il colore del proprio Sestiere. Tra l’altro il più stretto riserbo viene mantenuto sul cavallo che é tenuto nascosto. Su questa venerazione della cavalcatura l’aneddotica è infinita , pari cioè all’inventiva dei sestieranti come nel caso di cavalli, sosia dei veri destrieri, portati perfino alle prove generali per disorientare gli antagonisti.Queste cavalcature devono avere caratteristiche speciali per la Giostra , debbono essere curate e sostenute con attenzioni incredibili anche se a volte vengono fatti passare per "brocchi" in strumentali e provocatorii si dice. Un culto che tocca momenti e atteggiamenti perfino parossistici, come quel Sestiere che fece dormire il cavallo, di fronte alla figura del Moro ,con tanto di scudo per i punti , disegnata sopra la greppia onde farlo abituare a questa immagine, che avrebbe dovuto affrontare con coraggio e determinazione durante la gara.
Come detto, questa competizione ha per scenario naturale le strette vie medioevali della città, la Rinascimentale Piazza del Popolo ed il campo dei Giochi ove, in più assalti al Moro , i cavalieri si contendono la vittoria in una cornice di migliaia di spettatori che seguono rumorosi quanto trepidanti le evoluzioni dei propri giostranti.In particolare la spettacolarità del corteo storico offre una suggestiva sinfonia di colori rappresentati dai rigorosi costumi quattrocenteschi , dalle brillanti armature , dagli svettanti vessilli e dalla leggiadria delle rappresentanze femminili.
I costumi sono, ovviamente, un rifacimento in stile dei panneggi medioevali.
Essi sono stati desunti da affreschi e da altri disegni d’epoca. Non poche volte si ha l’impressione di vedere quasi animati , personaggi di Piero della Francesca , del Pinturicchio, di Paolo Uccello, del Crivelli e altri pittori del nostro Medioevo.
Anche per le armi, (le picche, le alabarde, le corazze, gli elmi, le grandi spade) si fa ricorso a vecchi disegni d’artigianato medioevale, ma non poche sono le armi autentiche che nobili ascolani ancora posseggono e conservano gelosamente e che solo nel giorno della Quintana permettono che vengano impugnate da cavalieri, armigeri e capitani. Lo stesso discorso vale per antichi strumenti di liuteria. Nel corteo storico,infatti, oltre alle figure militari e di magistrati, sfilano anche menestrelli , cavalier serventi di dame e damigelle ed alcuni di questi suonano e pizzicano strumenti d’epoca.
Un capitolo a parte meritano gli sbandieratori che sfilano in seno alle rappresentanze dei loro Sestieri, ricalcandone i colori e i simboli nei loro drappi, che scagliano in cielo con lanci che hanno del prodigioso( non per nulla alcuni di essi hanno vinto l’Olimpiade della Bandiera). Va però precisato che per tutto l’anno gli sbandieratori, con i loro maestri e registi studiano movimenti per coreografie sempre più attraenti e spettacolari, poiché nella prima domenica di Luglio partecipano ad una gara che si svolge sulla Piazza del Popolo per la conquista di un sospirato premio. Una gara che unisce ai movimenti di spettacolo, eleganza, abilità, agonismo più caloroso di protagonisti e supporters di Sestiere.
Nel giorno della Quintana, invece, gli oltre cento sbandieratori si esibiscono al Campo dei Giochi in una straordinaria coreografia d’insieme,con il lancio finale dei drappi che si perdono in cielo tra l’entusiasmo spontaneo ed irrefrenabile degli spettatori.
I Monumenti

Alto 6 m e lungo 12 m è formato da 15 tonnellate di bronzo fuso e 600 tonnellate di Travertino d'Ascoli.Rappresenta un gruppo di soldati, dapprima appena abbozzati che si vanno sempre più definendo fino ad arrivare alla figura del generale Erico Cialdini Nel retro è presente una piccola cripta.A ricordo di tutti i caduti nella battaglia di Castelfidardo è stato eretto anche un ossario
 Ad Ancona Elegantissimo, venne eretto dal Senato e dal popolo di Roma nel 100-116 d.C. ad opera dell'architetto siriano Apollodoro di Damasco in marmo turco (proveniente dalle cave dell'isola di Marmara) in onore dell'imperatore che aveva fatto ampliare, a proprie spese, il porto della città migliorando le banchine e le fortificazioni. Da qui lo stesso Traiano partì per la vittoriosa guerra contro i. Daci.
Ad Ancona Elegantissimo, venne eretto dal Senato e dal popolo di Roma nel 100-116 d.C. ad opera dell'architetto siriano Apollodoro di Damasco in marmo turco (proveniente dalle cave dell'isola di Marmara) in onore dell'imperatore che aveva fatto ampliare, a proprie spese, il porto della città migliorando le banchine e le fortificazioni. Da qui lo stesso Traiano partì per la vittoriosa guerra contro i. Daci.
Iacopo Molinaro
Giovanni Mancini
Giada Melmeluzzi
.jpg)

.jpg)
.jpg) con salsa verde a base di prezzemolo e lo stoccafisso, preparato in umido con patate o in `potacchio´,
ossia brasato con pomodoro, acciughe, aglio, rosmarino, prezzemolo e peperoncino. Tra i piatti tipici di montagna sono da provare la polenta costarella e salsicce,
la minestra di ceci e maiale, le uova fritte nel burro e cosparse di filetti di tartufo e l’insalata di funghi e tartufi.
con salsa verde a base di prezzemolo e lo stoccafisso, preparato in umido con patate o in `potacchio´,
ossia brasato con pomodoro, acciughe, aglio, rosmarino, prezzemolo e peperoncino. Tra i piatti tipici di montagna sono da provare la polenta costarella e salsicce,
la minestra di ceci e maiale, le uova fritte nel burro e cosparse di filetti di tartufo e l’insalata di funghi e tartufi..jpg)



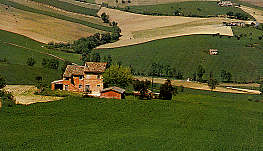 Il paesaggio collinare interessa il 53% del territorio ed è un tratto inconfondibile di questa terra. Si tratta di alture marnoso-arenacee che la natura ha distribuito sia a nord che a sud. L’uomo poi vi ha disegnato precisi appezzamenti delle più svariate forme geometriche con interminabili filari di pioppi e punteggiati da alberi d’ulivo o da rigogliose vigne. Alla sommità dei colli sorgono le ‘città balcone’ arroccate da secoli e testimoni della storia. Recanati, Urbino, Fermo, Camerino, Cingoli, Osimo, San Ginesio, Macerata, Loreto sono alcune delle più belle ‘città belvedere’. Nel Montefeltro, ai confini con la Toscana e la Romagna, prevale un ambiente aspro con scoscesi speroni rocciosi e giganteschi contrafforti di pietra come quelli su cui sono aggrappati San Leo e la Repubblica di San Marino. Più a mezzogiorno il paesaggio si addolcisce e compaiono dei colli in una successione sempre più sfumata. Nella punta meridionale dell’Ascolano, a ridosso del confine con l’Abruzzo, il terreno si increspa con maggior decisione, i pendii più ripidi e gli stacchi tra collina e pianura diventano più netti.
Il paesaggio collinare interessa il 53% del territorio ed è un tratto inconfondibile di questa terra. Si tratta di alture marnoso-arenacee che la natura ha distribuito sia a nord che a sud. L’uomo poi vi ha disegnato precisi appezzamenti delle più svariate forme geometriche con interminabili filari di pioppi e punteggiati da alberi d’ulivo o da rigogliose vigne. Alla sommità dei colli sorgono le ‘città balcone’ arroccate da secoli e testimoni della storia. Recanati, Urbino, Fermo, Camerino, Cingoli, Osimo, San Ginesio, Macerata, Loreto sono alcune delle più belle ‘città belvedere’. Nel Montefeltro, ai confini con la Toscana e la Romagna, prevale un ambiente aspro con scoscesi speroni rocciosi e giganteschi contrafforti di pietra come quelli su cui sono aggrappati San Leo e la Repubblica di San Marino. Più a mezzogiorno il paesaggio si addolcisce e compaiono dei colli in una successione sempre più sfumata. Nella punta meridionale dell’Ascolano, a ridosso del confine con l’Abruzzo, il terreno si increspa con maggior decisione, i pendii più ripidi e gli stacchi tra collina e pianura diventano più netti.
